
Introduzione
Sono tra coloro che ritengono Bruner uno dei quattro titani, insieme a Freud, Piaget, Vygotskij, che il secolo scorso ci ha donato nel campo della conoscenza.
“Come conosciamo” è tema ancora trascurato, nonostante la scuola sia l’istituzione in cui si apprende a conoscere. Ci occupiamo di come educhiamo, di come istruiamo, ma poco di come conosciamo, e qui non da un punto di vista psicologico.
La prima opera di Bruner pubblicata in Italia da Armando Armando nel 1964 è Dopo Dewey. Il processo di apprendimento nelle due culture.
Bruner lo scrive dopo aver partecipato alla Conferenza di Woods Hole con la quale gli Americani convocano nel Massachussetts, nel 1959, i maggiori scienziati e studiosi in tutti campi per mettere in discussione i propri programmi scolastici preoccupati di essere superati dai Sovietici che avevano lanciato nello spazio lo Sputnick.
Con il suo “Dopo Dewey” Bruner smonta il Mio credo pedagogico di John Dewey, compiendo lui sì un’autentica rivoluzione copernicana e non già l’illustre filosofo americano. Non più la scuola come luogo di trasmissione del sapere per partecipare alla cultura della propria specie, come sosteneva l’atto di fede deweyano, ma la scuola come istituzione in cui si apprende a conoscere, come luogo di negoziazione della conoscenza.
È sul tema della conoscenza che si esercita il mestiere dell’istruzione e dell’apprendimento, non come si trasmette, ma come si accede al sapere.
Di qui i temi di fondo della teoria dell’istruzione di Bruner che si muove tra strutturalismo e costruttivismo. L’importanza della scoperta come modo di avanzare in un apprendimento che si amplia a spirale, indagando la struttura delle discipline per rendere autonomo nel viaggio verso la conoscenza ogni singolo studente. La sintesi è nell’apprendere ad apprendere: learning to learn, learning how to learn, oggi divenuto patrimonio dell’Europa della società della conoscenza, manifesto dell’apprendimento permanente.
Lo stato delle nostre scuole
La realtà didattica delle nostre scuole è senza dubbio a macchia di leopardo, accanto a zone di eccellenza coesistono ancora diverse ombre. Quanto del contributo di Bruner si sia tradotto nella pratica quotidiana delle nostre scuole non sono in grado di dirlo.
La mia impressione è che sull’apprendere ad apprendere prevalga ancora l’insegnamento come trasmissione, ma vorrei sperare di sbagliarmi.
In uno dei saggi di questo libro dedicato alla mano sinistra Bruner introduce due tipi di insegnamento: l’insegnamento in forma enunciativa e l’insegnamento che si esplica in forma ipotetica. Due modi opposti del fare istruzione.
Nel primo caso lo studente è colui che ascolta “le decisioni dello speaker”, si direbbe in linguistica, è l’insegnamento ex cathedra. Nel secondo, nell’insegnamento in forma ipotetica, l’insegnante e lo studente sono invece in posizione cooperativa. Lo studente prende parte attiva alle esposizioni e alle formulazioni, e a volte può esplicarvi un ruolo principale. Può assumere anche un atteggiamento del tipo “come se”. Interrogativo, che è molto di più del semplice dubbio cartesiano, il “come se” della mano sinistra che immagina. Perché soltanto la forma ipotetica può caratterizzare l’insegnamento che incoraggia la scoperta e l’apprendimento a spirale.
Su tutto questo le nostre scuole sono ancora in mezzo al guado, e potrebbe succedere che riprendere in mano, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione in Italia, un libro come Il Conoscere. Saggi per la mano sinistra porti a scoprire che è ancora attuale.
Una comunità mitologicamente istruita
Intanto “Il conoscere”, il titolo originale è “On knowing. Essays for the Left Hand”, non un infinito sostantivato come è stato tradotto in italiano, ma un gerundio presente, non un punto di arrivo o un atto isolato, ma qualcosa che avviene nel presente con continuità tra passato e futuro.
Quel gerundio presente è la materia di cui è fatta la scuola di ogni giorno, la materia che accompagna ogni istante della nostra vita. La conoscenza nel suo manifestarsi, scorrere e divenire, il compiersi di un’azione, appunto: l’apprendimento.
“Il Conoscere. Saggi per la mano sinistra”. Saggi “occasionali” li definirà più tardi Bruner, di giorno porta avanti l’indagine psicologica, di notte si occupa di romanzo, di poesia, di teatro.
Il libro contiene saggi sulla creatività, sul mito, sull’identità, sul romanzo moderno, sull’arte come modo della conoscenza. Fino al saggio su Freud, colui che più di tutti è sceso negli abissi della conoscenza per rivelarcene i meccanismi più profondi.
Perché accostare l’arte all’istruzione, al knowing?
Perché scrive Bruner siamo una comunità “mitologicamente istruita”, con una sua “bussola interna”. Una comunità mitologicamente istruita che è un complesso di “identità” metaforiche. E qui c’è un richiamo alla lezione nietzschiana per la quale possediamo soltanto le metafore delle cose, non le entità originali.
Una comunità la cui impalcatura sono i miti, la cultura come grande rappresentazione che ci consente di riconoscerci nei suoi simboli, miti e metafore.
Nella nostra cultura mano sinistra e mano destra sono simboli e metafora, hanno sempre ingaggiato tra di loro una discussione aperta e a volte rumorosa, rappresentando le due culture, quella umanistica e quella scientifica.
Per i francesi à main gauche era il figlio illegittimo. Della mano sinistra noi diciamo che è impacciata, sebbene sia stato affermato che gli studenti d’arte possono conquistare una maggiore espressività nel disegno proprio cominciando ad usare la mano sinistra.
La mano destra rappresenta colui che fa, la sinistra colui che sogna. La destra è l’ordine e la legalità. Cercare la conoscenza con la mano destra è scienza. La mano sinistra è sentimento, intuizione, illegittimità.
Ma è anche vero che le grandi ipotesi della scienza sono doni che giungono dalla mano sinistra.
Prendiamo la tastiera di un pianoforte, le note più basse sono a sinistra, in modo che le note di basso che sono usate principalmente per l’armonia e il tempo siano suonate dalla mano sinistra e la mano destra affronta la melodia. Entrambe sono necessarie per una composizione musicale gradevole, così entrambi gli stili di pensiero, quello di destra e di sinistra, sono necessari per un insegnamento efficace.
La cultura come grande narrazione
Che cos’è la cultura se non una grande narrazione, perché l’uomo ha avuto bisogno di organizzare il sapere, frutto delle sue esperienze, in una grande narrazione, nel senso etimologico del termine di conoscere e divenire esperti, una narrazione condivisa, dai significati negoziati, nella quale riconoscersi come parte di una comunità.
E cosa c’è più potente “dell’economia metaforica” per dare rappresentazione all’esperienze dell’uomo, l’economia della metafora che si è tradotta in miti e simboli, in rappresentazioni mentali e in concetti, attraverso i quali pensiamo. I nostri costrutti mentali, per dirla con la neurolinguistica.
Questa narrazione è la cultura, e la cultura è il DNA della nostra società.
La struttura fondamentale di questa narrazione è il linguaggio, a sua volta una grande metafora.
Per dirla con Francesco Bacone la mente e la mano possono fare ben poco senza i sussidi e gli strumenti che li completano: il principale è il linguaggio e le sue regole d’uso.
Linguaggio e apprendimento
Il linguaggio è lo strumento principale dell’apprendimento a partire dalla lezione di Pensiero e linguaggio di Vygotskij.
Dal linguaggio emerge la rappresentazione del mondo, veicola la rappresentazione del mondo, i significati condivisi, il mondo concettuale.
Il linguaggio è lo strumento più potente con cui organizziamo l’esperienza, costruiamo la “realtà” delle cose.
Il linguaggio è il concentrato massimo di simboli e di metafore per eccellenza, ne è la sublimazione, è quello attraverso il quale si esprime una cultura, la cultura di una comunità.
Il linguaggio è uno strumento delicato, la sua attività combinatoria produce effetti sulla nostra rappresentazione del mondo, sul nostro pensiero, sul nostro stesso modo di pensare.
La mano sinistra combina simboli e metafore, la mano sinistra è quella del “come se”, il pensiero ipotetico che fa progredire arte e scienza, perché poi la destra organizza la nuova esperienza nella narrazione che si fa cultura.
Ma le combinazioni del linguaggio condizionano il nostro modo di vedere e di interpretare il mondo. Il linguaggio è strumento dell’insegnamento estremamente delicato e su questo dobbiamo riflettere per come arrivano i nostri messaggi e come essi possono condizionare la rappresentazione della realtà e i modi di pensare di chi ci sta di fronte.
Il linguaggio è l’esempio di come gli stessi simboli, con gli stessi identici significati possono combinare rappresentazioni differenti della realtà.
Si pensi alla frase “La borsa crollò, il governo diede le dimissioni” e come utilizzando gli stessi simboli, le stesse metafore, ma combinandole in modo differente la rappresentazione della realtà immediatamente cambi: “Il governo diede le dimissioni, la borsa crollò”.
È l’arte combinatoria della cultura umanistica, l’arte combinatoria della mano sinistra
conduce secondo Bruner alla “verità illuminante”, alla “sorpresa produttiva” senza le quali la grande narrazione della cultura non potrebbe avanzare, come la scienza non potrebbe progredire.

Henry Moore ricorre ai buchi nelle sue sculture per risolvere un problema squisitamente tecnico: dare un senso tridimensionale alle forme solide. “Il buco connette un lato con l’altro rendendo un corpo immediatamente più tridimensionale”. Un vuoto, un togliere per aggiungere. L’attività combinatoria della mano sinistra come momento cruciale della creazione. Ecco la verità illuminante, la sorpresa produttiva.

Come sorpresa produttiva e verità illuminante ritornano nella tenerezza di madre e figlio che esprime La Virgen Blanca, scultura gotica del XIV secolo conservata nella cattedrale di Toledo. Non c’è un sacro più umano capace di rappresentare l’amore tra madre e figlio di questo, costruito con l’abile artificio dell’uso del sorriso e della delicatezza delle mani, fino alla mano del bimbo che accarezza il mento della madre.
Ma per Bruner è anche opera d’arte, frutto dell’attività combinatoria della mano sinistra:
E=mc²
È probabilmente la più famosa formula della fisica, grazie all’intreccio di novità, semplicità ed eleganza.
Il 1905 è l’anno mirabilis di Albert Einstein, fino ad allora tutti pensavano che la massa e l’energia fossero due realtà fisiche molto diverse, completamente separate e senza punti di contatto. Ma Einstein comprende che queste due realtà fisiche, apparentemente così diverse, sono in verità strettamente legate da un valore numerico molto preciso: il quadrato della velocità della luce nel vuoto (c²). Questa geniale e semplice formula, che all’epoca risultò assolutamente rivoluzionaria, stabilisce che massa ed energia sono equivalenti, come se fossero le due facce della stessa “medaglia”.
La mano sinistra porta alla mano destra, il pensiero narrativo al pensiero paradigmatico della scienza.
La metacognizione
Per Bruner compito dell’istruzione è “andare a meta”, non nel senso del rugby, ma inteso come “metacognizione”. L’apprendimento come luogo della metacognizione. Il “Knowing”, gerundio presente che si inoltra nelle strutture della conoscenza. La conoscenza che indaga, che riflette su se stessa.
La scuola come luogo in cui si apprende a gestire il linguaggio quale potente strumento simbolico della cultura, come luogo della metacognizione per eccellenza, perché solo attraverso la metacognizione si può andare alla ricerca di sorprese produttive, di verità illuminanti. Perché è attraverso la metacognizione che si può giungere a scoprire come si è prodotta la grande narrazione e come essa si può ricreare.
La questione di come sono organizzate conoscenza ed esperienza nella molteplicità delle loro forme è come il ponte di pietra che il Marco Polo di Calvino descrive al Kublai Kan. Qual è la pietra che sostiene il ponte chiede il Kublai Kan, e Marco risponde che il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, ma dalla linea dell’arco che esse formano. Kublai allora protesta, rimproverando Marco di parlargli di pietre quando a lui è solo dell’arco che importa. Marco gli risponde che senza pietre non c’è arco.
Ecco, la metacognizione è l’insieme delle pietre che formano l’arco, e la scuola serve non per apprendere l’arco ma l’insieme delle pietre che consentono di disegnare l’arco.
La caduta del Mito
La mano sinistra espressione di una comunità “mitologicamente istruita”, una comunità di “identità metaforiche”.
Cinquant’anni fa Bruner prendeva atto che questa comunità aveva distrutto i suoi miti, perduto il suo filo d’Arianna, si è persa nel labirinto.
Il bisogno di mito è rimasto inappagato, rimpiazzato dalle mode.
Scienza, tecnologie e globalizzazione non sono sufficienti a dare risposte, soprattutto sul piano della creatività dell’arte.
La cultura stessa è un testo ambiguo, che ha costantemente bisogno d’essere interpretato da coloro che ne fanno parte.
Non si è comunità se non si condividono i significati, e la condivisione risiede nella negoziazione interpersonale.
La cultura è sempre più come un forum: un processo di continua costruzione e ricostruzione, di metacognizione in cui gli individui non sono spettatori, ma protagonisti.
Tutto questo è richiesto dalle continue sfide del presente e dal futuro che non ci è dato di sapere come sarà.
Il tempo delle certezze è finito, il nostro tempo è l’incertezza. Non abbiamo bisogno di saperi dati ma di strumenti per costruire i saperi futuri.
Il luogo in cui ci si prepara, non per adattarsi alla società, ma per affrontare il futuro è la scuola.
La scuola come luogo del forum della cultura, la scuola dei progetti, la scuola laboratorio che cozza con l’idea che il processo educativo consista in una trasmissione di conoscenze da chi sa di più a chi sa di meno, da chi è più competente e chi lo è di meno, da chi è preparato a chi è impreparato alla vita.
La pedagogia chirurgica
La pedagogia che ne scaturisce è una pedagogia chirurgica che concepisce l’insegnamento come un intervento chirurgico, un’operazione volta a sradicare, sostituire o colmare una lacuna. Ma noi veniamo da un secolo di Freud, Piaget, Vygotskij, che hanno posto in risalto il bambino che impara, i suoi bisogni di individuo autonomo che apprende, un’enfasi destinata ad avere un’importanza straordinaria.
Freud ha contribuito a mettere in risalto l’autonomia di funzionamento dell’io, il suo affrancamento dagli impulsi eccessivi e conflittuali. Piaget ha accentuato l’apprendimento come invenzione. Vygotskij il processo sociale di negoziazione del significato.
Quello che deriva è che quello dell’adattamento è un ideale troppo modesto, ammesso che possa essere ritenuto un ideale.
L’educazione non più come mezzo di adattamento alla società, ma come mezzo fondamentale della trasformazione della società. E qui dobbiamo dire che il meccanismo si è inceppato.
Come crescere una generazione nuova che sappia impedire al mondo di dissolversi nel caos e nell’autodistruzione, recuperare il suo filo d’Arianna.
Il linguaggio dell’educazione è il linguaggio dell’arte, della mano sinistra e della mano destra che suonano insieme lo stesso spartito, è il linguaggio della creazione di cultura, non solo dell’acquisizione o del consumo della conoscenza.
L’archetipo non è Edison quale geniale inventore, ma è Einstein quale potente pensatore. “Come se”, la mano sinistra.
Una scuola che a partire dalla mano sinistra sappia creare pensiero, predisporre il terreno alla mano destra. Non è dell’eros, della passione di un insegnante in grado di emozionare gli studenti, che abbiamo bisogno, ma di una scuola in grado di coinvolgere il pensiero, in grado di far funzionare la “mente a più dimensioni” per dirla con Bruner.
Quando Manet affermò che “la natura è solo un’ipotesi”, non poteva certo farlo nella prospettiva popperiana. Era il suo un grido di battaglia contro la pretesa del figurativismo accademico di costituire l’unica maniera, e anche la più giusta, di rappresentare pittoricamente la natura. Era un invito a creare una molteplicità di ipotesi diverse e perfino provocanti.
È il compito implicito della mano sinistra e della necessità che ha la mano destra delle attività di tipo umanistico che consentono di creare e sviluppare ipotesi.
Una teoria dell’istruzione
L’uomo è un membro della cultura che eredita e poi ricrea. Il potere di ripensare la realtà, di ripensare la cultura è il punto di partenza di una teoria dell’istruzione.
È necessario che la scuola, le classi non siano lasciate al loro isolamento dorato, ad un’autonomia che si traduce in autosufficienza, per cui la scuola non è più come una volta un corpo separato dalla società, ma è un corpo separato dalla cultura.
Va messo in cantiere uno sforzo collettivo che sappia per davvero prendere in mano il futuro del nostro processo educativo, uno sforzo nel quale tutte le risorse di intelligenza vengano messe a disposizione delle scuole.
Si devono trovare i mezzi per alimentare le nostre scuole con le conoscenze sempre più profonde che si vanno maturando alle frontiere della conoscenza.
Abbiamo bisogno di istituti per lo studio dei programmi scolastici, dove gli uomini di cultura, gli scienziati, gli uomini d’affari, gli artisti si incontrino regolarmente con insegnanti di valore per rivedere e aggiornare i nostri programmi.
Occorre condividere con gli insegnanti i risultati delle nuove scoperte, le prospettive aperte dalla ricerca, le nuove conquiste raggiunte sul piano dell’arte.
Dobbiamo avere le idee più chiare su cosa vogliamo insegnare, a chi e in che modo, se vogliamo contribuire a crescere esseri umani capaci di raggiungere i loro obiettivi.
Bisogna dire che Università e Istituzioni culturali non danno e non hanno dato aiuti preziosi.
Tutti gli Ocse Pisa del mondo non riusciranno a raggiungere l’obiettivo di dare nuova vitalità alla nostra società multiculturale e farne una società nella quale e per la quale valga la pena di vivere.
*Conferenza tenuta il 1 febbraio 2018 presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara nell’ambito del ciclo di incontri “I colori della conoscenza”, organizzato dall’Istituto Gramsci e dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.




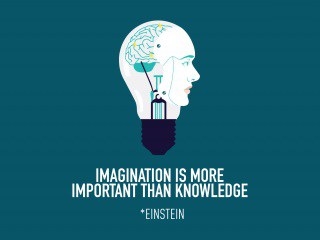




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.